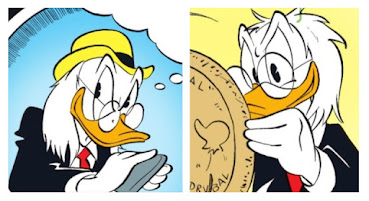SC: Simone Cavazzuti
DM: Ralph du Mosch
SC: Essendo un autore (super)nuovo, ho avuto qualche difficoltà a reperire informazioni biografiche su di te. Ti andrebbe di condividere qualcosa a proposito della tua vita e di come sei finito a scrivere fumetti? Conoscevi bene l'universo Disney?
DM: Sì, sono cresciuto leggendo fumetti Disney, anche se, stranamente, non ero un grande fan dei fumetti in generale. Ho sempre amato disegnare, per quanto mi ricordi. Da bambino, scrivevo spesso brevi storie che poi "illustravo" anche.
Quando avevo 6 o 7 anni, ho iniziato a leggere la rivista olandese Donald Duck e ho iniziato naturalmente a provare a disegnare anche quei personaggi. Ricordo che, da ragazzi, un amico e io creavamo i nostri "fumetti" di Paperino (solitamente un foglio A4 era una vignetta). Erano probabilmente pessimi sia nei "disegni" che nella "scrittura", ma sono ricordi piacevoli.
Un paio di anni fa, ho trovato un blog di Evert Geradts sul quale pubblicava alcune sue vecchie sceneggiature sotto forma di storyboard, sono rimasto davvero affascinato da questa combinazione di scrittura e disegno e ho immaginato: "forse potrei provare a farlo anch'io".
Nel 2020, durante il primo lockdown, ho improvvisamente avuto del tempo in più da trascorrere a casa e, per capriccio, ho deciso di provare a realizzare un paio di sceneggiature e di provare a mandarle all'editore. La risposta è stata molto positiva ed entrambe le storie sono state vendute. Più tardi, un paio di settimane dopo, ricevo una e-mail in cui mi si chiede se sia libero per scrivere una storia di 10 pagine delle Giovani Marmotte. Da allora, mi hanno chiesto di scrivere sempre più storie. E il resto è storia (molto breve).
SC: Quali sono i tuoi autori e artisti preferiti?
DM: Carl Barks è il mio autore preferito. Quando ero bambino, in biblioteca avevano molti volumi con solo storie di Barks e così ne ho lette molte da lì. Ho letto molto Barks anche a casa dei miei nonni: avevano conservato i numeri di Donald Duck degli anni Settanta e Ottanta che appartenevano a mio papà e a mio zio quando erano bambini e quei numeri ristampavano molte storie di Barks.
Era l'età perfetta per leggere quelle storie, intorno ai 7-10 anni. Ora, molte di queste avventure, come Zio Paperone e la Stella del Polo e Paperino e i terremotari, hanno per me un grande valore nostalgico. Se dovessi scegliere la mia preferita, sarebbe probabilmente Zio Paperone pesca lo skirillione; la maniera in cui la storia si sviluppa da una situazione apparentemente banale a una grande avventura sottomarina è un esempio così indicativo dello storytelling barksiano: invece di presentare le situazioni fantastiche come racconti supereroistici, raccontava le storie come se fossero potute accadere a te!
Le storie di Barks erano così ben costruite che mi ricordo di aver pensato: "perché si deve complicare le cose in questo modo!!" Ogni volta che pensavi di poter prevedere quello che sarebbe successo, capovolgeva le tue aspettative e ti chiedevi come diavolo i paperi avrebbero risolto i loro problemi. Barks non ha mai preso la via più facile per uscire da una storia (anche quando avrebbe potuto semplicemente farlo) e ha sempre fatto uno sforzo maggiore piuttosto che realizzare una "storia per bambini" mezza assurda. Questo è qualcosa che ammiro molto della sua narrazione ed è qualcosa che provo a fare anch'io: non scrivere qualcosa di facile e veloce pensando: "chi se ne frega, è solo per i bambini", ma cercare davvero di realizzare una bella storia, che sia divertente da leggere a tutte le età.
Devo avere letto molti altri autori Disney, ovviamente, ma a parte Barks non ho mai saputo i loro nomi! Sono cresciuto leggendo anche un sacco di storie italiane, dato che venivano pubblicate nei tascabili olandesi che leggevo, e le considero notevoli. Per quanto riguarda gli artisti, i miei preferiti da ragazzo erano Daan Jippes e Carlos Mota. Hanno stili differenti, ma quello che hanno in comune è lo stile di disegno fluido, quasi "snello", e quel meraviglioso senso di "leggerezza" dei personaggi, che sembrano quasi saltare fuori dalla pagina.
SC: Sia in De rijkeluis-race (du Mosch/Pérez, Fernández, 2022) sia in Een speciale gast (du Mosch/Alfonso, Fernández, 2022), troviamo il trio Topolino/Paperino/Pippo e ciò possibile perché in Olanda vivono tutti nella stessa città, Duckstad (Paperopoli). Siccome sono personaggi così ben caratterizzati da stare solitamente per conto proprio, è più difficile scrivere una buona storia in cui abbiano tutti il giusto spazio?
DM: Alla fine del 2020, l'editore mi chiede una "storia lunga" in cui Topolino, Paperino e Pippo partecipano a una corsa per risolvere una sorta di scommessa. Non avevo pensato di usare il trio, dal momento che anche nei fumetti olandesi si vedono raramente insieme per quanto ne so, ma sono rimasto piacevolmente sorpreso da come sia uscita la storia. Circa un anno dopo, mi chiedono un'altra storia con Topolino/Paperino/Pippo, questa volta una storia di dieci pagine sul compleanno di Pippo. Sembrava una premessa molto noiosa, ma ancora una volta i personaggi sembravano scriversi da soli. È molto piacevole vedere Donald recitare tra i suoi coetanei. Offre l'opportunità per un tipo diverso di storie rispetto a quelle con Zio Paperone e Qui, Quo e Qua. Inoltre, la sincerità e la natura gentile di Topolino e Pippo bilanciano alcuni dei personaggi più cinici come Paperino e Zio Paperone.
 |
| Alcune vignette dallo storyboard di Een speciale gast |
SC: In De komst van oom Fortunus (du Mosch/Ferioli, 2022), abbiamo il debutto officiale di Gustavo Paperone in una storia a fumetti. Vorrei sapere come ti è venuta questa idea e se hai ricevuto qualche commento dai redattori o dall'editore a proposito dell'utilizzo di un genitore di uno Standard
Character.
DM: Io stesso non ero così sicuro di farla franca, ma hanno accettato la storia e non hanno mai detto nulla a proposito. Per coincidenza, leggendo la tua intervista con Evert Geradts, ho notato che aveva usato lo stesso identico approccio per portare a termine la sua storia con Della Duck: la redazione non gli aveva chiesto una storia con Della in particolare, ma ne ha scritta una di sua spontanea volontà, sperando che l'avrebbero accettata.
Ma, siccome i redattori spesso cambiano cose nel testo, ho aspettato ansiosamente per vedere che non lo cambiassero in uno zio all'ultimo minuto; fortunatamente, non lo hanno fatto. Cèsar Ferioli è un altro meraviglioso artista di cui ricordo le opere dalla mia infanzia e ha fatto un incredibile lavoro con le illustrazioni della storia.
Per me, la tradizione secondo cui i personaggi non hanno genitori sembra una limitazione autoimposta agli scrittori, dal momento che così tante trame comiche possono derivare da una dinamica genitore-figlio. Posso in qualche modo comprenderlo con Paperino, dal momento che molti lettori probabilmente vedono Nonna Papera come la madre di Paperino, e anche con Qui, Quo e Qua lo capisco, perché ciò solleverebbe la domanda sul perché vivono con Paperino e non con i loro genitori, ma per gli altri personaggi non vedo la necessità di mantenere mamma e papà un mistero.
Pensavo che non sarebbe stato divertente avere il padre di Gastone come una copia carbone di Gastone stesso, o "addirittura più fortunato di lui, bla bla bla". Pensavo che sarebbe stato più divertente renderlo un sergente istruttore, ossessionato dalla disciplina e dal duro lavoro. Ho preso ispirazione dalle storie del Lupo Cattivo, nelle quali il padre e il figlio sono agli antipodi.
 |
| Gastone alle prese con il padre nello storyboard di De komst van oom Fortunus |
SC: Pensi di far tornare Gustavo in futuro?
DM: Sì, ho ancora un paio di idee in testa per storie con Gustavo. Probabilmente, però, dato il mio lento ritmo di lavoro, riuscirò a trasformarle in storie finite solamente in un futuro distante. Ovviamente, anche altri autori potrebbero utilizzare il personaggio, siccome ora è lì fuori.
SC: Quello che mi piace nelle tue storie sono le combinazioni insolite dei personaggi, che permettono di mostrare alcuni aspetti che non erano stati mai (o comunque non così funzionalmente) esplorati prima. Cuordipietra contro Paperone e Ciccio in Zio Paperone e la sfida matematica (du Mosch/Pérez, Fernández, 2022), il "triangolo romantico" tra Paperino, Miss Paperett e un Bassotto in De kaart van Eugenia (du Mosch/Pérez, Fernández, 2022), e così via... Come ti vengono queste idee e ci sono altri personaggi che vorresti esplorare?
DM: La prima cosa che le persone mi chiedono quando gli dico che scrivo fumetti Disney è: "da dove ti vengono le idee?" e non riesco mai a dare una risposta interessante. Faccio solo brainstorming in base ai parametri che l'editor mi fornisce, oppure un'idea mi viene in mente a caso durante il giorno e (se non mi dimentico di scriverla) provo a vedere se riesco a tirarne fuori una storia.
La combinazione dei personaggi non nasce da uno sforzo consapevole. Cerco semplicemente di ottenere una storia che non abbia letto prima, qualcosa che mi sarebbe piaciuto leggere da bambino. E, quando cerchi di entrare nel "territorio inesplorato", provi giocoforza combinazioni di personaggi che non si erano visti insieme prima. Per esempio, mi è appena stata pubblicata una storia in cui Herbert, l'amico di Qui, Qui e Qua, parte per un'avventura assieme a Zio Paperone. Dimmi se non è una strana coppia!
SC: A proposito di Herbert, come mai pensi che sia un personaggio così popolare in Olanda?
DM: Bella domanda. Credo sia perché la produzione barksiana è molto radicata nei fumetti olandesi. Come il cane Bolivar e il vicino Jones, Herbert è un personaggio popolare qui, ma raramente (forse mai?) appare in storie straniere. Inoltre, il suo nome olandese, "Keessie", ha un suono divertente e orecchiabile.
SC: A proposito dei fumetti olandesi, credo che la qualità dei disegni dei vostri artisti sia notevole. Le tue storie per ora sono state disegnate da Jippes, Ferioli, Pérez... Quanto è soddisfacente vedere quello che scrivi in una veste grafica così bella? C'è qualche artista (olandese e non) con il quale sogneresti di collaborare?
DM: Daan Jippes è stata una sorpresa totale per me e, solo la settimana scorsa, mi è stata pubblicata una storia disegnata dal mio altro artista preferito, Carlos Mota!! Dopo avere ammirato le loro opere da quando ero un ragazzo, pensare che un giorno avrebbero disegnato le mie storie è quasi surreale.
Ci sono molti altri artisti con i quali spero di lavorare su mie storie un giorno: Mau Heymans è un altro dei preferiti dalla mia infanzia. Ci sono anche nuovi nomi, come Tim Artz, Henrieke Goorhuis e Jan-Roman Pikula, che sono tra i migliori cartoonist che io conosca.
Kari Korhonen è un altro dei miei preferiti, che ha lo stesso stile "fluido" e leggermente buffo che ammiro in Jippes e Mota. Ma Korhonen lavora solo per Egmont, perciò dovrei prima vendere una storia a loro affinché ciò possa accadere.
SC: Mi hai raccontato da dove viene l'ispirazione per le storie, ma poi come sottoponi il tuo lavoro ai redattori e all'editore una volta terminato? Realizzi una sceneggiatura scritta oppure lo consegni sotto forma di storyboard?
DM: Solitamente, il redattore mi chiede un numero preciso di pagine per un dato personaggio e, spesso, mi viene dato un tema generico che la storia dovrà sviluppare (ad esempio, "eredità" o "caccia al tesoro"), nonostante io mi prenda molte libertà. Altre volte, creo semplicemente una storia senza che me lo chiedano e la invio, come avevo fatto la prima volta. In questo caso, ho più libertà di decidere quante pagine saranno, ecc., e queste storie non hanno una data di consegna, perciò ho più tempo per lavorarci.
Una volta che ho completato la storia, disegno l'intero script sotto forma di storyboard (molto) veloce e abbozzato; tutti gli autori per la produzione olandese lavorano così. La parte più difficile per me è capire come avere il giusto numero di vignette nel limite della pagina. C'è spazio solo per 8 vignette per pagina, ma a volte vorresti una vignetta più grande, o più piccola, se la storia lo richiede. Mi piace avere delle grandi vignette iniziali, ma ciò significa che dovrò rimuovere o accorciare una vignetta da qualche altra parte nella storia per fare combaciare il tutto e, se quando sommi tutte le vignette, ce n'è una di troppo, devi ricominciare a ricomporre il puzzle da capo: aarggh!
Sebbene le bozze possano essere veloci e non debbano essere grandiose, aggiungono MOLTO lavoro in più alla stesura di una sceneggiatura, ma mi piace dare l'input visuale alla storia. Realizzo il primo design per ogni nuovo personaggio che posso creare per le mie storie e ogni volta è molto divertente vedere come l'artista finale lo interpreta. Ad esempio, Nelis de Nozem, il consulente per la gestione della rabbia di Paperone in Innerlijke rust: Paco Rodriguez ha fatto suo il personaggio, aggiungendogli una piccola treccia sotto becco che lo ha reso molto più divertente!
 |
| Nelis de Nozem da Innerlijke rust (du Mosch/Rodriguez, 2021) |
Una volta che la sceneggiatura è completamente scritta e abbozzata, la invio alla redazione e il mio editor la leggerà e deciderà se acquistarla o rifiutarla. All'inizio, ricevevo spesso note su cose che andavano cambiate. Ad esempio, nella storia con Ciccio, Cuordipietra avrebbe dovuto drogare Ciccio mettendogli dei sonniferi nel cibo. A quanto pare, non si poteva fare, così l'ho sostituito con un orologio ipnotico raffigurato sul cartellone di un tifoso (molto inverosimile, lo so, ma probabilmente anche più divertente). Fortunatamente, con il passare del tempo, ho ricevuto meno note e la maggior parte delle storie viene accettata senza bisogno di modificare nulla (toccando ferro!).
Ciò che avviene successivamente è fuori dal mio controllo e la storia verrà assegnata a un artista.
Spesso, la redazione cambia la mia sceneggiatura per renderla più breve o più semplice ed è un peccato a volte, perché mi piace mettere dell'umorismo nei dialoghi che viene quindi tagliato per rendere il testo più breve. Secondo me, il testo non dovrebbe essere troppo semplice, ma dovrebbe sfidare un po' i bambini, in modo che possano migliorare inconsciamente il loro vocabolario in una maniera che li diverta. Molti bambini che leggono la rivista sanno già leggere perfettamente, perciò non ritengo che debba rimanere a un livello prescolare.
Inoltre, devo sottolineare che, mentre ovviamente ci guadagno un po' di soldi, quello del fumettista non è il mio "lavoro principale", ma è essenzialmente un hobby, e perciò devo utilizzare il mio tempo libero per farlo. Questo significa anche che ho pochissimo tempo per lavorare alle mie storie e, a volte con le scadenze, devo fare molto lavoro in tempi brevi! Perciò, alcune storie risultano un po' più affrettate di altre, ma cerco comunque di fare il meglio che posso.
SC: Qualche commento su progetti a cui stai lavorando?
Sto anche lavorando a una storia di 9 pagine con Archimede e una di 10 pagine con Amelia, oltre ad avere molte idee "in cantiere", ma, come ho detto, queste storie non commissionate richiedono più tempo per essere completate.
 |
| Vignetta iniziale dallo storyboard di Strijd om een erfenis |
 |
| Vignetta iniziale dallo storyboard di Pech gehad! |
SC: Sentiti libero di aggiungere qualsiasi cosa di cui non abbiamo parlato durante questa chiacchierata.
DM: Non ho molto da aggiungere, se non ringraziarti per la decisione di intervistare me: l'autore di fumetti MENO conosciuto al mondo!
Ti auguro buona fortuna con il tuo blog e spero che altre mie storie vengano pubblicate in Italia, affinché i lettori italiani possano (si spera!) apprezzarle.
© Disney per le immagini pubblicate.













































%20-%20pagina%2089.jpg)






%20-%20pagina%2047.jpg)