 |
| Gastone Paperone in Paperino e la caccia al tacchino (Barks, 1960) |
 |
| Oscar Paperone in Zio Paperone e il nipote portasfortuna (Chendi/Scarpa, 1966) |
 |
| Gastone Paperone in Paperino e la caccia al tacchino (Barks, 1960) |
 |
| Oscar Paperone in Zio Paperone e il nipote portasfortuna (Chendi/Scarpa, 1966) |
 |
| Rockerduck alla sua seconda apparizione americana (?/Wright, 1971) |
 |
| Wormsley Bookdust (Barks, 1949) |
 |
| Scuylor Vanderbandit (Lockman/Strobl, 1966) |
%20-%20pagina%2089.jpg) |
| ... ma non in Italia |
 |
| Confronto tra il Rockerduck di Wright pubblicato in America (stile barksiano) e in Italia (adattamento allo stile internazionale prevalente) |
 |
| Una via di mezzo tra la versione barksiana e quella attuale (Kinney/Scarpa, 1964) |
 |
| La trasformazione è quasi completata (Barosso, Barosso/Scarpa, 1964) |
 |
| Zio Paperone e la caccia alle bottiglie (Kinney/Bradbury, 1965) |
%20-%20pagina%2047.jpg) |
| Zio Paperone e la giostra delle battaglie (?/Wright, 1966) |
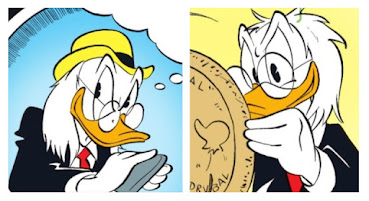 |
| Hannibals Elefant (Gulbransson, 2013) e In den wilden Bergen (Gulbransson/Gulbransson, Rodriguez, 2013) |
 |
| De tre milliardærer (Korhonen, 2015) |
La mia corrispondenza elettronica con Carlo Chendi iniziò, credo, nel 2010. All’epoca, gli scrivevo chiedendo informazioni riguardanti sue vecchie storie, dettagli, ispirazioni, e lui mi rispondeva sempre rapidamente, raccontandomi tutti i retroscena e parlando con grande passione dei suoi lavori. Ricordo che, discorrendo della storia Topolino contro il “magnifico snello” (Chendi/Rebuffi, 1976), che io avevo letto su un numero de I Grandi Classici Disney, Chendi aveva memoria solo di alcuni dettagli (come i nomi dei pianeti, che giocavano su luoghi reali di sua conoscenza) e non della storia nella sua interezza, e mi manifestò il desiderio di rileggerla. Così, quando ci incontrammo nell’aprile dell’anno seguente, durante una cena nella sua Rapallo in occasione della consegna a Don Rosa del Premio Papersera, regalai a Carlo la mia copia de I Grandi Classici (con la copertina mancante) e lui ne sembrava veramente entusiasta; nella fotografia, lo si può vedere mentre sfoglia l’albo raccontando ai commensali quella storia misteriosa. Nella stessa occasione, Chendi mi fece dono di un libretto da lui edito su Carl Barks in occasione dell'edizione della Mostra Internazionale dei Cartoonists dedicatagli a Rapallo nel 2005, e di una copia di tutte le lettere inviategli da Barks tra il 1967 e la fine degli anni ’90; un omaggio molto apprezzato da cui traspare tutto il suo amore per il mondo dei comics.
 |
| Carlo sfoglia le pagine de Il magnifico snello e io alle sue spalle (Rapallo, aprile 2011) |
CH: Sì, in particolare con Bottaro,
con il quale ho iniziato questa professione. Abbiamo cominciato praticamente
insieme: le mie prime storie le disegnava Bottaro, poi Bottaro aveva anche tanto
da fare... poi il direttore gli passava storie anche di altri, allora io facevo
altre storie per la Mondadori che il direttore passava ad altri disegnatori: a
Scarpa, a Carpi, poi a Cavazzano quando ha cominciato a lavorare. Tra l’altro,
delle prime cinque storie di Cavazzano quando ha iniziato a lavorare per la
Disney, quattro sono sceneggiature mie. E con Cavazzano siamo rimasti molto
molto amici, ci siamo visti la settimana scorsa. Anche con Bottaro, Scarpa e
Carpi c’era un ottimo rapporto, un rapporto di collaborazione, ma anche di
stima.
SC: Negli anni, ha preferito
scrivere per qualche disegnatore piuttosto che altri?
CH: I primi tempi scrivevo per
Bottaro perché abitava a Rapallo, al quinto piano sopra di me. Dopo Bottaro, ho
lavorato con Cavazzano, assieme al quale ho creato i personaggi di OK Quack e
Umperio Bogarto.
SC: Se non sbaglio, su I
Grandi Classici, stanno ristampando alcune storie di OK Quack.
CH: Non lo so, perché non ho modo di vedere le ristampe. Da un po’ di anni non compro più niente; di solito me le mandano, ma non so più dove metterle. La Disney mi ha spedito i primi ventidue libri di Scarpa [ndr. L’Opera omnia di Romano Scarpa] e sono appoggiati lì per terra, non mi ci sta più niente da nessuna parte. Qualche volta mi dicono: “ti mandiamo questo”, e io dico: “no, perché non so dove metterli” [ride]. Uno che cura la composizione delle ristampe è Luca Boschi e ogni tanto mi comunica che ha scelto delle storie mie. Poi sono in contatto con Marcelo Alencar, che è il traduttore delle storie Disney per la Abril in Brasile, e anche lui mi ha mandato le mie storie pubblicate in Brasile... poi mi ha fatto un’intervista. Le storie mie Disney sono state pubblicate in ventiquattro paesi: negli Stati Uniti, la Russia, tutta l’Europa, e adesso anche in Cina.
 |
| Premio Copertina d'Argento (The Walt Disney Company Italia, 1994) |
SC: Le è mai capitato che
l’editore le modificasse i testi o le chiedesse di cambiare qualcosa
all’interno delle sue storie?
CH: Direi di no. La redazione
qualche volta poteva tagliare una frase se non ci stava materialmente nel
fumetto. Io, poi, non mandavo mai le storie all’approvazione perché c’era un
rapporto fiduciario con i direttori. Pensa che ho fatto una storia che per
l’epoca, il 1960, era una novità, che è stata Paperino il paladino, dove
tutti parlano in un italiano antico maccheronico. Era una cosa che non era
concordata con il direttore. Quando Bottaro l’ha disegnata, abitualmente me la
ridava che controllavo i dialoghi e nel vederla così mi è venuto in mente di
studiare il linguaggio. Mi sono fatto una specie di dizionario, cercando di fare
la caricatura dell’italiano antico ma che fosse capito dalla generazione
dell’epoca. L’ho mandata al direttore senza dirgli niente e lui l’ha pubblicata
senza dirmi niente, senza cambiare nulla. Quel tipo di linguaggio che avevo
inventato, poi, Monicelli l’ha copiato per L’armata Brancaleone,
uguale identico. Gentilini e Capelli, che sono stati i direttori per i quali ho
lavorato di più, non mi hanno mai controllato o censurato niente, perché evidentemente
c’era un rapporto di fiducia. Io penso che il vero editore, una volta che ha
testato un autore e si rende conto che sa fare il proprio lavoro e lo sa fare
bene, non abbia bisogno ogni volta di controllarlo o cambiare le cose che fa,
altrimenti sarebbe meglio non farlo lavorare. Uno dei motivi, a mio avviso,
della crisi del Topolino da quando è andato via Capelli è che i
direttori che sono arrivati dopo hanno voluto intervenire nella creatività e
l’hanno smorzata; Casty mi dice, ad esempio, delle difficoltà che ha qualche
volta con questa redazione [ndr. la direttrice era Valentina De Poli] nel
fargli approvare alcune storie, perché probabilmente non le capiscono. Il
compito del redattore, a mio avviso, è quello di controllare che non ci siano
sbagli di grammatica, di sintassi, coordinare le cose, ma non intervenire nella
creatività.
SC: Una volta, lo stile di disegno
era più eterogeneo: pensi a De Vita padre, Scala e altri artisti con uno stile
particolare; mentre i nuovi disegnatori hanno uno stile più omologato e simile.
Cosa ne pensa?
CH: Un po’ è dovuto alla redazione, che vuole un prodotto omogeneo, e un po’ è dovuto anche al fatto che gli artisti tendono ad accodarsi a stili già esistenti. Una volta, non era così: per esempio, Gentilini non è mai intervenuto sulle storie di De Vita padre, che aveva uno stile totalmente non disneyano, non è mai intervenuto sulle storie di Scala o di Perego. Li ha lasciati disegnare con il loro stile. E quando il Topolino usciva, tu lo sfogliavi e li conoscevi: questa storia è di Perego, questa è di Scarpa, questa è di De Vita padre. Adesso, il Topolino è tutto uguale. C’è una omogeneità che da un certo punto di vista può funzionare per la redazione, ma secondo me i lettori preferirebbero ancora trovare lo stile e la personalità degli artisti. L’omogeneità viene accettata mediamente da tutti, la differenza no. Ad alcuni magari non piacevano le storie di Perego, ma secondo me quello era un punto positivo proprio per sottolineare la creatività e la diversità che c’era nella produzione di questi fumetti.
 |
| Chendi nel suo studio (Rapallo, agosto 2014) |
SC: Al momento sta lavorando a
qualcosa?
CH: No [ride]. Sto facendo
qualche altra sceneggiatura, ma non per la Disney. Perché io ero abituato con i
vecchi direttori che si fidavano di me e ora confesso che mandare delle mie
storie in redazione e poi sentirmi dire: “questo non va, cambia perché…”,
preferisco di no. Sono stato abituato a lavorare per tutti gli editori senza
mandare storie all’approvazione: ho lavorato per vent’anni per il Giornalino,
ho lavorato per il Corriere dei Piccoli, il Corriere dei
Ragazzi. Sia il direttore dell’uno che dell’altro non mi hanno mai chiesto
di mandare delle storie all’approvazione, tutt’al più mi dicevano: “manda una
storia di sei pagine, dieci, ma arrangiati”, invece con la Disney adesso… Poi, è
una questione anche di rincoglionimento dovuto all’età [ride]: io credo che un
redattore di venticinque/ventisei anni ne sappia meno di me e quindi non credo
di avere niente da imparare da loro, forse loro avrebbero qualcosa da imparare
da me.
SC: Si è affezionato a qualche
personaggio?
CH: Soprattutto alla famiglia
dei paperi, che sono quelli che ho usato di più... di Topolino ho fatto poche
storie; gli altri personaggi a cui ero e sono molto affezionato sono Pippo e
Nocciola. Tra l’altro, con Pippo ho fatto anche delle storie diverse con il corvetto
che ha usato anche Scarpa [ndr. Gancio], Pippo lo sento come un mio
personaggio. E poi Umperio Bogarto e OK Quack.
SC: Vuole dire qualcosa sul suo
rapporto con Barks?
CH: Io ho imparato a fare le storie da Barks. Aveva una qualità innovativa nell’impostare le storie per i comics. La sua tecnica, l’umorismo e il modo in cui faceva recitare i personaggi erano veramente grandi e io ho imparato di lì. Non sapevo chi fosse, cercavo di conoscere il suo nome, ma praticamente non lo sapevano neanche alla Disney; perché Barks non lavorava per la Disney, lavorava per la Western Printing, che era tipo una Mondadori, cioè un editore licenziatario Disney. Poi, nel ’65, Alfredo Castelli, che si occupava di fumetti da appassionato prima di diventare un professionista, su una fanzine americana ha trovato l’indirizzo di Barks. Io gli ho scritto dicendo che ero un suo allievo, l’ho chiamato “Maestro”, e dal ’65 [ndr. in realtà dal ‘67] in avanti ci siamo scritti per più di vent’anni. Poi, nel ’93 mi pare [ndr. era il ‘94], lui è venuto in Europa, mi ha scritto dicendo: “passo dai vari paesi europei e vengo anche in Italia”, allora l’ho invitato a Rapallo e lui ha detto: “vengo volentieri”. Infatti, è venuto a Rapallo, siamo andati a mangiare al ristorante dei fumetti di U Giancu. È venuto perché eravamo amici.
SC: Era una persona amichevole?
CH: Era la persona più umile che abbia conosciuto. Si meravigliava ancora che tanti apprezzassero le sue storie. Quando gli ho detto: “hai fatto delle storie meravigliose”, mi ha risposto: “mi venivano così”.
 |
| L'allievo e il Maestro (Chendi e Barks) |
SC: Ancora oggi è ristampato
ovunque.
CH: Barks è eterno, ha fatto
delle storie che sono dei classici. Alcuni personaggi non dei fumetti sono
cresciuti leggendo le storie di Barks, due in particolare: Steven Spielberg e
George Lucas. Tra l’altro, Spielberg da giovane è andato a trovare Barks perché
era un suo ammiratore, Lucas uguale. Quando ho fatto la mostra dedicata a
Barks, sapevo che Lucas aveva scritto un articolo su Barks e allora volevo
pubblicarlo, però ovviamente con il suo permesso. Sono riuscito a trovare fortunosamente
il suo indirizzo a Los Angeles, gli ho scritto, sono passati due mesi e non mi
ha risposto. Poi, dopo due mesi, ricevo la sua lettera, non avevo quasi il
coraggio di toccarla, il quale mi si scusa dicendo che non mi ha risposto prima
perché era in vacanza, tornato dalla vacanza ha trovato la mia lettera; l’articolo di Barks lo potevo pubblicare gratis, senza nessun problema!
SC: Pensa che oggi ci sia
qualche autore in grado di scrivere storie che durino?
CH: Non lo so perché lo seguo
poco. Due autori che conosco meglio, a parte Cavazzano che è uno dei “vecchi”,
e che secondo me hanno un grande talento sono Casty e Artibani. Artibani lo
conosco bene, la sua prima storia di Paperino era il rifacimento di una storia
mia [ride]. Un altro molto bravo che fa delle belle cose è Celoni, anche Mottura.
Però oramai loro tendono a fare anche storie per altri editori: Celoni fa Dylan
Dog, Mottura ha fatto adesso una storia per Bonelli. Invece, uno che si
dedica solo a quello è Casty. Anche Artibani ha fatto le Winx e un sacco
di altre cose, però è molto bravo, pieno di talento.
SC: Cosa ne pensa dei nuovi
metodi di disegnare in maniera digitale?