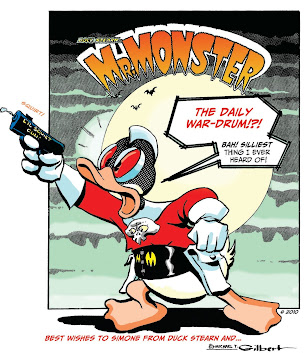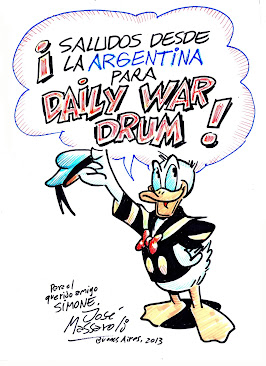Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Cornelius
Coot, il fondatore di Paperopoli introdotto nella storia Paperino e il maragià del Verdestan (Barks, 1952); se la vostra mano è rimasta
abbassata, probabilmente saprete anche che Cornelius è il nonno di Nonna
Papera, giusto? E se vi dicessi invece che potrebbe non esserlo? Per fare ciò,
dovremo: tornare indietro nel tempo fino a quando il personaggio è stato
concepito, capire da dove questa presunta relazione provenga e fare un pochino
di ricerca su elementi che potrebbero dimostrarne l’inconsistenza.
Partiamo dall’inizio: 1952, nella storia menzionata poco
sopra, il sindaco e il sovrintendente ai monumenti vengono cacciati
dall’ufficio di Paperone dopo avergli chiesto “poche migliaia di dollari per
erigere una statua a Cornelius Coot”, il fondatore della città. Barks citerà
questo personaggio in altre due storie, Paperino e la statua acquatica
(1957) e Paperino e la macchia d’inchiostro (1957); ma, ogni volta che i
paperi hanno in qualche modo a che fare con lui, non menzionano il fatto di
esserne discendenti, riconoscendolo semplicemente come il fondatore della città, e Paperino si riferisce a lui come “il vecchio pioniere”. Ciò esclude
automaticamente la possibilità che loro siano effettivamente i suoi
bis-bis-bisnipoti? Probabilmente no, ma sicuramente appare strano: Cornelius
sembra essere amato dalla comunità e (almeno) Paperino non perderebbe di certo
l’opportunità di mostrare con orgoglio tale relazione.
 |
| Paperino si riferisce a Coot come "il vecchio pioniere" (Barks, 1957) |
Ma quindi l’idea di questa parentela dove ha origine? Io
credevo provenisse direttamente dal famoso albero genealogico del cartoonist statunitense Don Rosa (e dalle sue storie a fumetti), ma apparentemente mi
sbagliavo, siccome esistono almeno due riferimenti più oscuri precedenti ad
esso. Questa relazione viene infatti teorizzata per la prima volta da un gruppo
di studiosi tedeschi, conosciuti con lo pseudonimo Grobian Gans, nel loro
libro Die Ducks — Psychogramm einer Sippe (1970); successivamente, nel 1984, un artista ancora oggi ignoto include Cornelius
tra gli antenati di zio Paperone all’interno di un albero genealogico molto ricco (contenente vari personaggi da storie di Barks, Strobl, Bradbury, nonché Paperoga e Pico de Paperis), pubblicato in un volume olandese (Donald Duck 50 jaar in beeld). Interessante notare che, nello stesso volume, viene
pubblicata la storia Buon compleanno, Paperino! (Rota, 1984), in
cui zio Paperone e Nonna Papera sono fratelli (relazione peraltro mantenuta anche
nell’albero genealogico citato poco sopra). Nonostante lo sforzo di includere
tutti quei personaggi apparsi una sola volta sia lodevole e mostri certamente molta
dedizione da parte degli autori, preferirei non prendere in considerazione
questi alberi perché la loro portata non era molto ampia all’epoca e passerei
direttamente a Don Rosa, che probabilmente non aveva alcuna idea della loro
esistenza ed è giunto quindi alla stessa conclusione per conto suo.
 |
| La primissima connessione tra Coot e la famiglia dei paperi (Gans, 1970) |
Come sappiamo, Rosa colloca Cornelius
Coot come nonno di Nonna Papera e, siccome l’autore del Kentucky è conosciuto
per essere sempre stato fedele al lavoro dell'Uomo dei Paperi, questa scelta potrebbe
sembrare un po’ fuori luogo a primo impatto, ma credo che il suo ragionamento
sia facilmente ricostruibile. Lo stesso Barks introduce infatti un cugino dei
paperi chiamato Cuthbert Coot nella storia Paperino cow-boy (1945) e
menziona un altro cugino Coot (forse lo stesso) in Paperino e le perle
(1948). Perciò, il fatto che il cugino di Paperino ha lo stesso cognome del
fondatore di Paperopoli ha probabilmente indotto Rosa a ritenerli imparentati
in qualche modo, ma io credo si tratti di una prova troppo debole: Coot
potrebbe semplicemente essere un cognome diffuso a Paperopoli. Questa relazione
è stata comunque validata da alcuni autori successivi; in storie italiane
post-Rosa, come ad esempio Paperino e la corsa al best-seller (Cordara/Barbucci,
1998), Zio Paperone e il gigante di Paperopoli (Panaro/Migheli, 2014), Paperino e il ritrovamento storico (Panaro/Urbano, 2017) e Paperinik e il cimelio del fondatore (Panaro/Soldati, 2019), viene esplicitamente asserito che
Nonna Papera è nipote di Cornelius. E ancora la parentela (e dunque
l’appartenenza di Nonna Papera alla famiglia Coot) è generalmente accettata tra
fan e appassionati, al punto tale da essere considerata canonica nel recente
reboot di DuckTales; ma, nonostante questo indirizzo sembri quindi essere
affermato, ci sono un paio di indizi che potrebbero far cambiare idea e farlo
apparire invece come una qualche sorta di fanfiction d’autore semi-ufficializzata.
 |
| Il cugino Cuthbert Coot (Barks, 1945) |
 |
| Nella continuity italiana Cornelius Coot è accettato come nonno di Nonna Papera (Cordara/Barbucci, 1998) |
Innanzitutto, non esistono testimonianze a partire dalla
data di creazione di Nonna Papera (1943) fino all’inizio della produzione
donrosiana (fine anni ‘80/inizio anni ’90) dell’appartenenza dell’anziana
papera alla famiglia Coot. Infatti, se non contiamo alcune storie italiane
(come quella di Rota menzionata un paio di capoversi fa) in cui viene presentata
come sorella di zio Paperone, è sempre stata considerata membro della famiglia Duck: in Il compleanno di Nonna Papera (?/Thomson, 1950), scopriamo infatti che il suo
nome completo è Elviry Duck, cambiato poi in Abigail in Nonna Papera a Hollywood (Fallberg/McSavage, 1953) e Topolino e la ferrovia Toccaferro
(Fallberg/Murry, 1955). Qualcuno potrebbe obiettare dicendo: “aspetta un attimo,
queste non sono delle vere prove, Duck potrebbe semplicemente essere il cognome
che ha preso in seguito al matrimonio” e ciò certamente non contraddirebbe il
lavoro di Rosa (semmai ne sarebbe a favore), ma, in Paperino e il tesoro di Barbabiforcuta (?/Alvarado, 1971), ci viene presentato Asa Duck,
pro-pro-prozio di Nonna Papera. Il fatto che questo parente porti il cognome
Duck e che Nonna Papera sembri essere orgogliosa descrivendolo come “uno dei
primi cittadini di Paperopoli”, senza nemmeno menzionare l’esistenza di
Cornelius (probabilmente sarebbe ancora più orgogliosa se fosse la nipote del
fondatore della città), mi fa pensare che tale relazione sia infondata.
 |
| Nonna Papera si chiama Elviry Duck (?/Thomson, 1950) |
 |
| Nonna Papera orgogliosa del suo pro-pro-prozio Asa Duck, uno dei primi cittadini di Paperopoli (?/Alvarado, 1971) |
Ma ci sono altri elementi che accrescono il dubbio. Innanzitutto,
nella maggior parte delle storie a fumetti in cui appare (il database INDUCKS
ne conta 21 già prima dell’avvento di Rosa nel 1987, ma ne trascura alcune in
cui viene solamente menzionato), Cornelius è considerato da Paperino e famiglia
solo un pioniere e non effettivamente un parente; per citare un esempio
(pescato giusto a titolo dimostrativo tra le decine di usi analoghi di cui
sopra): in Paperino e la "graande impresa" (Pezzin/De Vita,
1988), Paperino sospira pensando a “Cornelius Coot, l’eroico paperopolese!”,
senza mai riferirsi a lui come un proprio antenato. Questa mancata parentela è
resa ancora più evidente in The Red Duck (Anderson/Colomer Fonts, 1990):
il nuovo vicino di casa di Paperino si vanta del fatto che un suo antenato è
stato uno dei primi sindaci di Paperopoli, Paperino si innervosisce e vuole
dimostrare che anche i suoi antenati sono stati importanti, ma non ne conosce
nemmeno uno (cosa mi dici di un certo Cornelius Coot, fondatore di
Paperopoli?), in qualche modo riesce a viaggiare nel tempo fino ai primordi
della città per fare la conoscenza del suo antenato più (in)famoso, un certo
pirata chiamato appunto the Red Duck. Sebbene mi sembri abbastanza
chiaro ora che la famiglia dei paperi non discenda dai Coot (almeno non dal
ramo di Cornelius), un indizio ancora più palese viene fornito nella più recente The New
Year's Curse (McGreal, McGreal/Rota, 2015), in cui un flashback ci mostra
proprio il fondatore della città alle prese con un suo sergente, tale Bridger
Duck, vero antenato di Paperino (altri discendenti di Bridger sono menzionati
nella stessa storia: Beauregard Duck, Casey Duck e Draper Duck).
 |
| Paperino si riferisce a Coot come "l'eroico paperopolese" (Pezzin/De Vita, 1988) |
 |
| Paperino non conosce i propri antenati (Anderson/Colomer Fonts, 1990) |
 |
| Cornelius Coot alle prese con il suo sergente Bridger Duck, antenato di Paperino (McGreal, McGreal/Rota, 2015) |
Quindi, l’intenzione di Barks di non avere Coot come un
antenato dei paperi era certamente sottintesa e non esplicitata, ma è stata
accettata da autori dopo di lui che l’hanno resa più evidente; come visto sopra:
i paperi stessi non lo considerano mai un parente, Nonna Papera fa parte di un
ramo della famiglia Duck, e ci sono evidenze di antenati di Paperino in vita ai tempi di
Cornelius. Ma, se tutto questo ancora non fosse abbastanza, è possibile
tracciare la vera discendenza di Cornelius Coot attraverso un minimo di
ricerca. Tre eredi sono infatti presentati in altrettante storie:
- In Archimede l’aggiustatore folle (Fallberg/Strobl, 1970), possiamo vedere Cornelia Coot (bis-bisnipote di Cornelius) mentre arriva a Paperopoli per rivivere le memorie dell’infanzia; mai viene menzionata una sua eventuale parentela con la famiglia dei paperi, e questo la dice lunga dal momento che anche Nonna Papera appare nella storia;
- In Nuts On The Family Tree (Marschall/Lopez Guardia, 1983), Zio Paperone vorrebbe provare la propria discendenza da Cornelius Coot; alla fine della storia, però, non solo si scopre che il miliardario non ha nessun grado di parentela con il fondatore della città, ma vediamo anche un vero erede del pioniere: un maggiordomo di Paperone chiamato Dopeleigh;
- Il terzo vero parente viene proposto dall’autore italiano Carlo Chendi, grande ammiratore del lavoro di Barks, suo amico di penna per più di trent’anni (fin dal 1967), e il primo sceneggiatore in assoluto ad aver utilizzato il personaggio di Cornelius Coot — dopo Barks stesso — in Archimede Pitagorico e l’uomo medio (Chendi/Capitanio, 1961). Ebbene, in Zio Paperone mecenate per forza (Chendi/Cavazzano, 1993), il detective Umperio Bogarto scopre di discendere “per vie traverse” da Cornelius Coot. Per chi non fosse familiare con questo personaggio, basti sapere che appare in 89 storie tra il 1982 e il 2019 e mai viene menzionato un suo collegamento con la famiglia dei paperi.
 |
| Cornelia Coot (Fallberg/Strobl, 1970) |
 |
| Il maggiordomo Dopeleigh discende da Coot (Marschall/Lopez Guardia, 1983) |
 |
| Umperio Bogarto discende "per vie traverse" da Cornelius Coot (Chendi/Cavazzano, 1993) |
In conclusione: Cornelius Coot è il fondatore di Paperopoli?
Certamente sì. Anche se, volendo essere super completi e precisi, altri paperi
hanno ricoperto in passato lo stesso ruolo: Dwight Duck in Foto-storia della grande tribù (?/Strobl, 1959), Zio Paperone (!) in Paperon de' Paperoni pioniere (Gregory/Strobl, 1960), Penwick Duck in Paperino dà lustro al clan (Lockman/Strobl, 1967), Don Pepito Paperon in Paperino e le pepite di don Pepito Paperon (Martina/Scala, 1977), Daniel Papero in Zio Paperone e la gloria... spicciola (Lockman/?, 1988) e Paperyn McPap in Paperino e i cugini di Ocopoli (Salvatori/Scala, 1996); queste possono però
essere ovviamente considerate trascurabili eccezioni dal momento che Coot ha
fatto più di 200 apparizioni considerando soltanto i fumetti (e non contando
quindi cartoon e statue nei parchi tematici Disney) e, come i nipotini ricordano a
Paperino in Paperino e il fondatore finanziario (Sisti/Leoni, 1995),
“tutti sanno che Paperopoli è stata fondata da Cornelius Coot!” Il periodo in
cui Cornelius avrebbe fondato Paperopoli è un altro argomento dibattuto poiché,
nonostante la maggior parte degli autori (compreso Don Rosa) sia concorde a
collocarlo all’interno del diciannovesimo secolo, alcune fonti come The Incredible Quest for Cooties (Kruse/de Jonge, 1991) sembrano invece farlo
risalire a un tempo precedente (in questo specifico caso, addirittura al diciassettesimo secolo). Ma, aldilà di queste controversie, il punto
qui è: Cornelius Coot è o non è nonno di Nonna Papera e quindi antenato di
Paperino? La mia risposta, e spero di averla articolata in modo chiaro ed efficace, è naturalmente no. Come mostrato nel corso di questa ricerca, non ci sono indizi di ciò nella produzione di Barks e la maggior parte degli autori successivi a lui (ad eccezione di Rosa e altri ispirati al suo lavoro) ha evitato questa
connessione, preferendo invece lasciare un alone di leggendarietà intorno a
questo personaggio così tanto ammirato dai cittadini di Paperopoli (compreso
Paperino), fornendo inoltre antenati alternativi coevi a Coot e veri
discendenti del pioniere completamente estranei alla famiglia Duck.
 |
| "Tutti sanno che Paperopoli è stata fondata da Cornelius Coot!" (Sisti/Leoni, 1995) |
Questo post è una versione ampliata e corretta di un articolo scritto per la fanzine danese Rappet, le immagini pubblicate sono © Disney.